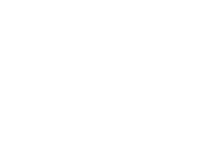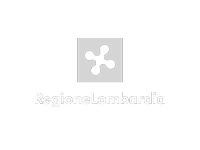Se si considera la comunicazione d’impresa oggi in Italia si ha l’impressione che ci sia sempre più voglia di storia, nel senso che le aziende, se hanno una corporate heritage, sentono il bisogno di raccontarla, di valorizzarla. È così? E perché, a suo parere, in questo momento storico?
Potremmo provare a vedere come sono cambiati sia i mercati sia la collocazione delle imprese italiane. Stare sui mercati globali significa affrontare due questioni. La prima: prodotti standard per pubblici di massa. La seconda: prodotti specifici per target determinati, tagliati quasi su misura del singolo utente che apprezza la differenza e l’identità. Dentro i mercati globali c’è sia la tendenza all’omogeneizzazione che quella alla specialità. Che cosa hanno i prodotti italiani? Un forte elemento identitario. La cucina italiana, l’arredamento italiano, la moda italiana, ma anche la nostra meccanica, la farmaceutica, la meccatronica, l’industria navale, la plastica e la gomma hanno caratteristiche specifiche, cioè sono portatrici di identità forti per consumatori e utenti esigenti. La storia, in un mondo in cui si può emulare e copiare tutto, non è copiabile: ognuno ha la propria. Quindi per le imprese italiane valorizzare l’essere stati è una condizione fondamentale per continuare a essere, come ha insegnato un grande storico, Fernand Braudel. La nostra identità, la nostra storia sono formidabili e inimitabili asset di competitività. In sintesi, nell’evoluzione dei mercati il dato identitario premia. Dato identitario che è anche un elemento di qualità. Non vendi identità, vendi la caratteristica complessiva di un prodotto/servizio di cui l’identità è una componente fondamentale, insieme alla sostenibilità, alla qualità, alla riconoscibilità, alla capacità di essere ritagliato su misura, al limite del singolo utente.
Se l’obiettivo primario di un’azienda che abbia un’heritage, cioè una storia, è quella di valorizzarla, come conciliare questa esigenza con la parola «discontinuità» che aleggia come un mantra sulla nostra società, influenzandola in tutti gli aspetti, da quelli politici a quelli economici?
La storia non è una linea omogenea e continua, ma un insieme di eventi. E nel suo corso ha fratture, deviazioni, contraddizioni, discontinuità. La storia degli umani è una storia di discontinuità. Il suo percorso lungo non è continuità ripetitiva, bensì insieme di evoluzioni, di conflitti e di composizioni. L’interpretazione hegeliana della storia è fondamentale da questo punto di vista: tesi, antitesi e sintesi. La storia procede per fratture, per salti, per ricomposizioni, per recuperi e per avventure. Questa è la storia. C’è una frase molto bella di quel grande innovatore della musica del Novecento che è stato Gustav Mahler. Dice Mahler: «Tradizione (cioè la continuità) non è adorazione delle ceneri, ma è culto del fuoco». Il fuoco non è mai uguale a se stesso, il fuoco è una variazione continua. Analogamente, le aziende sono mutazioni nel corso del tempo. La ripresa della loro storia è valorizzazione della loro capacità di essere costantemente innovative man mano che cambiavano i contesti produttivi e tecnologici, le strutture commerciali, i riferimenti con i singoli Paesi, i rapporti di lavoro, le culture sottostanti ai processi di produzione. Per questo leggere la storia come una linea continua è un errore, la storia è l’andamento variabile e spesso sorprendente delle scelte delle persone, dei gruppi sociali, della comunità.
Torniamo al tema del racconto della corporate heritage, a suo parere esistono modalità migliori rispetto ad altre per far filtrare all’esterno la propria identità e i propri valori oppure tutti i linguaggi si equivalgono?
No, i linguaggi non sono mai identici, ogni linguaggio ha una sua dimensione specifica. Vale la pena di riflettere sul fatto che il racconto di un’impresa ha bisogno di essere polifonico, usare cioè tutti gli strumenti possibili. Un’impresa può essere raccontata dalle sue immagini: e dunque bisogna aprire le nostre fabbriche, le nostre imprese, ai fotografi e ai filmaker. Si possono utilizzare tutti i nuovi linguaggi legati alle tecnologie. E perché non aprirsi, per esempio, ai blogger? Perché non ai fotografi su Instagram? Una delle iniziative di maggior successo di Museimpresa, di cui sono Presidente, è stato affidare a un fotografo molto bravo su Instagram, Simone Bramanti, il racconto dei musei d’impresa. Bramanti sa descrivere bene, con due immagini, la variabilità dei singoli musei e archivi d’impresa. Ecco un altro buon esempio di uso del linguaggio innovativo: portare il lavoro d’impresa, la tecnologia, le relazioni personali che sono all’interno di un’impresa su un palcoscenico di teatro. In Pirelli abbiamo anche sperimentato come il racconto di una fabbrica particolarmente innovativa, a Settimo Torinese, progettata da Renzo Piano, potesse avere un racconto per musica: abbiamo chiesto a Salvatore Accardo e all’Orchestra da Camera Italiana di scrivere Il canto della fabbrica. Nato guardando ai ritmi di produzione della fabbrica digitale e poi interpretato per la prima volta proprio lì, dove quel canto era nato, cioè in fabbrica, dentro la struttura produttiva, quel Canto della fabbrica è il racconto di una struttura produttiva progettata da Renzo Piano, in mezzo a un giardino di 400 alberi di ciliegio, con le tecnologie più moderne e più sostenibili che l’industria di pneumatici possa avere oggi. Tutti gli strumenti del racconto, insieme, vanno utilizzati. Il presupposto qual è? Da parte nostra, cioè delle donne e degli uomini di impresa, aprire le nostre strutture produttive allo sguardo dell’altro, a uno sguardo esterno. E poi avere l’intelligenza progettuale di raccontarsi non come propaganda, non come pubblicità, ma come racconto. Detesto due parole, la prima è «storytelling»: è parola finta, che sa di propaganda aziendale, non indica quello che ci serve. La seconda è «narrazione», che è diventata un elemento della “lingua di legno” della politica. Mi piace invece parlare di racconto, cioè di capacità di rappresentare valori, culture, abitudini, sfide, tecnologie, innovazione, prodotti, trasformazioni, aprendoci e facendoci «raccontare», avendo cioè il coraggio della sfida dei nuovi linguaggi ma anche dei linguaggi tradizionali. Perché non un grande racconto letterario sulla fabbrica? Perché non un film, una rappresentazione teatrale sulla fabbrica, in modo da arrivare al pubblico, soprattutto a quello più giovane, le bambine e i bambini delle scuole elementari, alle ragazze e ai ragazzi delle superiori? Bisogna raccontare che l’impresa è un posto straordinario in cui realizzare i propri progetti e i propri sogni.
Parlando del racconto, un domani lo potrebbe vedere proiettato anche nel metaverso?
E perché no? Il metaverso è uno delle strutture possibili del linguaggio, da usare senza alcun pregiudizio. Ok al metaverso, quindi. Ma senza abbandonare i linguaggi tradizionali solo per seguire la novità. Il racconto umano ha sempre visto un adeguamento del linguaggio alla realtà da raccontare. Una poesia sulla fabbrica e contemporaneamente una rappresentazione della fabbrica nel metaverso, una poesia della fabbrica nel metaverso, perché no?
Mi piace molto il suo riferimento al mondo dei giovani, al mondo della scuola. Come arrivare a comunicare a questo pubblico la realtà, la storia e la bellezza delle imprese?
Intanto con pazienza e lungimiranza, aprendoci, facendoci guardare e, perché no? Criticare. Una delle idee più acute e di successo di Federchimica, molti anni fa quando l’industria chimica era sotto accusa anche per riflesso di alcuni eventi di inquinamento, è stata quella di organizzare un’iniziativa che si chiamava «Fabbriche aperte»: farsi vedere, avere il coraggio e la responsabilità di farsi osservare. Ma d’altra parte se tu decidi, come buona parte delle imprese italiane ha fatto, che una caratteristica specifica della tua identità è la sostenibilità ambientale e sociale, sai anche che questa scelta va giudicata, va osservata, non può essere greenwashing, operazione strumentale, un fiocco, un elemento di packaging. È una scelta produttiva profonda che l’impresa deve avere la disponibilità a rendere visibile e trasparente. Fare vedere, aprirsi alle scuole, stabilire con loro, fin dalle elementari, un rapporto continuo sul fare, sul produrre, sul fabbricare, sul trasformare materia prima in prodotto, sull’adattare l’intelligenza delle donne e degli uomini alle modifiche delle abitudini, dei consumi e delle esigenze. Ecco, questo è proprio un racconto appassionante. E tutte le volte che lo facciamo troviamo un ascolto molto attento. Dalla Fondazione Pirelli passano oltre 3000 studenti all’anno, da moltissimi altri archivi e musei d’impresa ne passano decine di migliaia. Credo che questo processo vada fortemente potenziato. Il lavoro che si fa in Confindustria sulla Settimana della Cultura d’Impresa va esattamente in questa direzione: aprirsi, farsi conoscere, farsi leggere. Perché le cose che facciamo hanno un loro profondo fascino: donne e uomini, che passando dall’impresa, provano a dare il loro contributo positivo all’evoluzione della Storia.
La scuola è parte del territorio e le aziende con una connotazione heritage sono intrise dei valori del territorio. Come avviene l’interscambio tra queste due realtà?
Ritorniamo a una delle più belle definizioni della storia dell’economia e dell’impresa italiana che si possa leggere nei libri, quella di Carlo Maria Cipolla, uno dei più grandi storici dell’economia europea. Diceva Cipolla che «gli italiani sono abituati, fin dal Medioevo, a produrre all’ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo». All’ombra dei campanili: la storia dell’impresa italiana è storia di territori produttivi, non è storia di company town, tranne Torino capitale dell’auto, ma è l’unica in Italia. Tutto il resto delle nostre imprese è disseminato nella provincia italiana. E grazie a questo rapporto sono in grado di mettere a sistema le culture produttive dei singoli territori. L’industria aeronautica nella zona di Varese, l’industria cantieristica che non è soltanto sul mare, a Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Venezia, ma si trova in moltissime realtà legate, per esempio, ai laghi – i più bei motoscafi italiani, i Riva, si sono sempre fatti e si continuano a fare sul lago d’Iseo. E poi la nostra industria farmaceutica, fortemente legata nei territori alla tradizione antica dei monasteri di utilizzare i prodotti della terra per fare farmaci. L’acqua che ha determinato l’andamento dell’industria tessile nelle valli di Biella e tra Schio e Valdagno in Veneto. La nostra storia, insomma, è storia di competenze artigiane che diventano industriali nel corso della storia sui singoli territori. Questa cultura del fare che si adatta all’ambiente è una delle caratteristiche per cui oggi riusciamo a realizzare prodotti di grandissima qualità per le esigenze più diverse dei mercati globali, per le varie nicchie a maggior valore aggiunto. I territori dicono anche un’altra cosa: la relazione forte tra produzione, culture, scuola, comunità, ambienti, amministrazioni virtuose.
Questo punto è molto interessante. A suo parere c’è ancora molto da fare per trasmettere ai territori e alle comunità i valori delle imprese oppure la simbiosi è a tal punto perfetta da rendere superfluo questo racconto?
No, non è superfluo affatto, C’è invece moltissimo da fare perché purtroppo la consapevolezza della maggior parte dell’opinione pubblica italiana rispetto ai valori e alle opportunità delle imprese è carente. Un recentissimo sondaggio di Federmeccanica ha evidenziato che, alla richiesta di aggiungere un aggettivo alla parola «industria», il 18% degli intervistati – quasi uno su cinque — non sapeva cosa dire. La maggior parte degli altri intervistati diceva «obsoleta»! Proprio noi, che abbiamo un’industria estremamente innovativa, che siamo il secondo Paese manifatturiero europeo proprio per l’innovazione che abbiamo saputo mettere in campo. Solo una percentuale minore diceva «produttiva». Ora, noi siamo un Paese che cresce perché esiste un’eccellente manifattura, altrimenti non avremmo avuto una crescita del quasi 11% del PIL tra il 2021 e il 2022. Ma la consapevolezza generale non è adeguata a quello che realmente succede. Noi non conosciamo noi stessi, non sappiamo qual è la forza economica e sociale del nostro Paese. L’impresa è collante sociale, è strumento di inserimento. Strumento di relazione oltre che realtà che produce lavoro, profitto, benessere. Ma non lo sappiamo, non lo diciamo. Ecco, è necessario, indispensabile battere quella diffusa cultura anti-impresa che purtroppo è ancora molto, troppo, diffusa.
I musei d’impresa possono aiutare in questa comunicazione?
È il nostro ruolo, la nostra responsabilità culturale e civile. Il compito dell’associazione Museimpresa, che raduna quasi 130 tra musei e archivi d’impresa e sostenitori istituzionali, è quello di far crescere la consapevolezza del ruolo fondante della cultura d’impresa. Cui spetta il miglioramento degli equilibri sociali e di quelli ambientali.