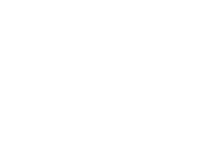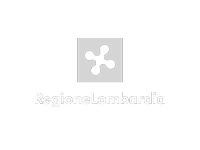Ci sono tre motivi che rendono la visita al Me\Bo, il museo Menabrea Botalla, di Biella un’esperienza singolare e inaspettata. Il primo è che rappresenta l’apice di una collaborazione ormai ventennale, quella tra il birrificio Menabrea, il più antico del nostro Paese essendo stato fondato nel 1846, e il caseificio Botalla, più giovane e non di poco – più o meno un centinaio d’anni –, che si potrebbe considerare quasi un format da proporre nelle business school: una sinergia operativa tra due aziende fortemente legate allo stesso territorio, quello biellese, che ha portato non solo alla creazione del primo formaggio italiano alla birra dall’ironico nome di “Sbirro”, ma anche alla scelta di partecipare sempre in tandem a eventi e manifestazioni fieristiche legati al food nonché all’idea di unire il racconto della storia delle due realtà aziendali in un unico museo d’impresa, appunto il Me\Bo. Franco Thedy, amministratore delegato di Menabrea, è assertore convinto della validità di questa visione imprenditoriale: “oggi siamo conosciuti nel mondo agroalimentare come un’entità unica, un segnale forte per il territorio biellese che dimostra come con un’intelligente collaborazione si possano ottenere risultati migliori rispetto alle strategie imprenditoriali individuali”. Certamente ha aiutato il solido presupposto di una vera amicizia tra lui e Andrea Bonino, CEO di Botalla, così come la chiara assunzione che “nessuno guarda il portafoglio dell’altro”, sta di fatto che questo connubio rappresenta nel suo pensiero solo una tappa nella realizzazione di un network di imprese locali che, ognuna a suo modo e con la propria identità, possono raccontare la storia di un territorio “di grandi lavoratori, di appassionati del proprio mestiere e dei propri prodotti”. Per esempio, pochi sanno che proprio qui, in piena Seconda Guerra Mondiale nel 1944-1945, venne siglato un accordo tra imprenditori, operai e partigiani, il cosiddetto “Patto della Montagna” volto a migliorare le condizioni di lavoro nelle industrie tessili del Biellese e che stabiliva, tra l’altro, la parità retributiva tra uomo e donna, un’anticipazione delle conquiste successive a livello nazionale che ancora oggi fanno fatica a essere applicate. Senza contare che molti imprenditori locali più di una volta si opposero alle squadracce fasciste che, dopo gli scioperi del’43, avrebbero voluto entrare nelle fabbriche per “dare una lezione” agli operai e aiutarono economicamente le famiglie degli arrestati. L’accordo, che era segreto, di fatto svincolava la contrattazione tra industriali e operai dalla mediazione corporativista con il sindacato fascista e apriva già la strada alla ricostruzione della società su basi democratiche, ponendo su un livello paritetico di negoziazione i due contraenti. Un pezzo di Storia, quella con l’iniziale maiuscola, da valorizzare e da porre tra gli esempi dell’indipendenza di pensiero, della fierezza e del coraggio di una terra ricca di valori con la ritrosia a comunicarli tipica delle comunità montane.
Che Menabrea e Botalla si considerino quasi un’entità unica lo si capisce già a partire dal logo del museo con le due sillabe Me e Bo separate da uno slash ma con la e e la B che si toccano: il primo dettaglio è la rappresentazione grafica della via di Biella, Ramella Germanin, dove le due aziende si trovano, dirimpettaie, da sempre visto che nessuna delle due si è mai allontanata dal suo luogo di origine, il secondo evoca l’amicizia che le lega, ulteriormente corroborata dal fatto – ci viene raccontato da Lisa Giardino, responsabile del Me\Bo – che in passato le cantine sotterranee di Menabrea e Botalla pare fossero comunicanti, una sorta di predestinazione architettonica a una collaborazione futura più che stretta. Il museo è nato per gradi, dapprima, nel 1996, come piccolo spazio interno a Menabrea dedicato più che altro ai clienti e allestito con vecchi macchinari del birrificio che una volta dismessi erano stati relegati in qualche soffitta e lì abbandonati (“da bravi biellesi, non buttiamo via niente” ride Lisa), ampliato poi nel 2016 con la decisione di acquisire un locale adiacente all’azienda per fondare Casa Menabrea, incentrata sulla birra e sul processo di birrificazione in una sequenza di racconto che partendo dalle materie prime arrivava fino alla fase di imbottigliamento. Nel frattempo erano nati la collaborazione con Botalla e il progetto dello Sbirro, il formaggio aromatizzato alla birra ambrata e avviato alla stagionatura avvolto negli scarti di lavorazione della bevanda, la cosiddetta “trebbia”, e da lì alla decisione di cambiare ancora una volta faccia al museo unendo le storie delle due imprese è stata questione solo di un passo.
Oggi la struttura, inaugurata nel 2019, si articola su due livelli, dei quali l’inferiore è dedicato alla birra e a Menabrea, il superiore a Botalla e alla sua produzione casearia. Ma c’è di più. Dall’altro lato della strada si apre Me\Bo Experience, una doppia area polivalente che può essere utilizzata anche da realtà terze o da partner per convegni o per la didattica. La sua vera anima però è proprio quella che si estrinseca nel nome, un luogo dove far sperimentare l’accostamento tra birra e formaggio e insegnare i segreti della degustazione di una bevanda che ha un’antichità e una dignità pari a quelle del vino, ancora però non del tutto riconosciute (“Peccato – si rammarica Thedy – che ancora oggi qualsiasi ristorante abbia la sua vetrinetta con le bottiglie di vino disposte ordinatamente alla giusta temperatura, mentre le bottiglie di birra vengono spesso ammucchiate dove capita, magari vicino al motore del condizionatore d’aria”).
Il futuro ha il sapore dell’ambizione: è in fase di ristrutturazione un nuovo spazio destinato a ospitare innanzitutto l’archivio storico di Menabrea, 45 metri lineari di documenti relativi per lo più alla famiglia che verranno resi fruibili ai visitatori attraverso un processo di digitalizzazione, e in seconda battuta una ricca biblioteca con libri dal 1500 a oggi incentrata sull’agrifood: “stiamo raccogliendo in modo compulsivo da ogni dove – dice Thedy – materiali che noi intendiamo custodire, restaurare, manutenere, dandogli il giusto rilievo e così facendo valorizzare anche le persone che ce li hanno dati in uso e le loro passioni”. Ci sarà anche la Meboteca, un’area espositiva di quadri, bicchieri, specchi, sempre tutti connessi con il mondo della birra (sì, non vi stupite, gli specchi nella loro versione pubblicitaria sono tutt’altro che rari, anzi sono sempre stati un elemento di arredo dei pub e dei locali di mescita della birra). Insomma, l’intenzione è quella di fare del Me\Bo “un centro di eccellenza vocato alla divulgazione della cultura birraria”, un progetto che per la sua natura non avrà mai un punto di arrivo e d’altronde un museo d’impresa non va forse tenuto vivo con sempre nuove iniziative? L’orgoglio risuona nella voce di Thedy quando sottolinea che tutto quello che è stato fatto e che si farà si è basato solo sulle sue forze e su quelle dei partner più stretti. “Nessuno ci ha dato nulla” dice e nel frattempo snocciola le cifre: l’anno scorso i visitatori sono stati 3000, un numero di tutto rispetto anche a paragone di musei d’impresa molto più grandi e famosi, e oggi il Me\Bo è una delle attrazioni del Biellese, muovendo così positivamente anche l’indotto, ulteriore riprova che la cultura d’impresa può essere motore di turismo laddove magari scarseggiano chiese e castelli – cosa che, almeno per quanto riguarda le prime, qui non vale visto che siamo a due passi dal celebre santuario di Oropa, con cui il birrificio ha un legame sacrale molto forte (nello stabilimento si incontra un po’ ovunque l’immagine della Madonna nera).
L’area del museo incentrata su Menabrea ha un’impronta chiaramente didattica – con la spiegazione passo dopo passo, e sala dopo sala, di come si produce la birra – impreziosita dai “reperti storici”, cioè dai macchinari della fabbrica di ieri, recuperati e restaurati. Anzi, “il Me\Bo – dice Lisa Giardino – è il museo in Europa con il maggior numero di utensili originali”. Alcuni tra questi sono stati in uso fino a tempi recentissimi come la bella calotta in rame (il nostro primo pezzo iconico) che era il coperchio della grande caldaia in cui veniva lavorato il cosiddetto mosto: una sorta di birra grezza, precedente alla fermentazione, che si genera dal riscaldamento di una miscela di acqua e malto e che successivamente viene bollita per poi essere filtrata (e sono proprio i residui solidi che ne derivano a essere destinati ad avvolgere le forme dello Sbirro). Per Lisa questo oggetto, oltre ad avere un’indubbia valenza estetica, è il simbolo della valorizzazione della corporate heritage dell’azienda e della consapevolezza della sua importanza per l’oggi.
Un’altra macchina interessante è l’imbottigliatrice utilizzata in Menabrea fino ai primi del Novecento: a quel tempo un operaio svelto riusciva a imbottigliare fino a 170 bottiglie all’ora (l’automatizzazione odierna fa raggiungere il numero stupefacente di 15.000 bottiglie all’ora). Le bottiglie non avevano etichetta, ma il nome del produttore semplicemente in rilievo sul vetro. Erano anche quasi sempre a rendere perché dopo l’utilizzo venivano recuperate e lavate, una pratica oggi non più disponibile a Biella (una bella foto in esposizione mostra la sala lavaggio in Menabrea alla fine dell’Ottocento).
Dicevamo che tutti gli attrezzi e i macchinari esposti sono di proprietà del birrificio. In realtà c’è un’eccezione: una curiosa macchina, di produzione austriaca, appartenente al Ministero delle Finanze. Utilizzata fino agli anni Settanta, serviva per calcolare il potenziale grado alcolico della birra prodotta, sulla base del suo contenuto zuccherino, per determinare l’entità della tassazione dovuta allo Stato.
L’ultima sala racconta il passato di Menabrea – qui si trova il secondo pezzo iconico del museo, il grande albero genealogico che inquadra tutti i protagonisti di questa straordinaria avventura imprenditoriale – e si ricollega al secondo motivo per cui la visita al Me\Bo è un’esperienza preziosa: apre uno squarcio vivido della storia non solo del Biellese, ma anche di quella parte dell’Italia nordoccidentale costituita da Valle d’Aosta e Piemonte, collegandosi a una delle civiltà alpine più affascinanti: quella dei Walser. Sì, perché tutti i personaggi che hanno avuto a che fare con il birrificio erano e sono Walser. E qui una piccola digressione è di dovere.
Intorno al XII secolo in tutta le regioni del Nord Europa e del Nord America si registrarono temperature più alte della norma: fu il cosiddetto optimum climatico medievale che determinò l’arretramento di tutti i ghiacci. Fu grazie a esso che i Vichinghi, per esempio, riuscirono a colonizzare la Groenlandia la cui stessa etimologia (green land, terra verde) dice molto su come appariva ai primi occhi europei. E fu sempre in seguito a questa anomalia climatica che molti passi alpini divennero praticabili. Cominciò così una lenta migrazione verso sud di quelle genti di origine alemanna, i Walliser o Walser nella forma abbreviata del loro nome, che per l’appunto occupavano la zona della Svizzera che oggi corrisponde grosso modo al Vallese. Non dobbiamo immaginare uno spostamento in massa, un’orda inarrestabile, bensì un passaggio dall’altra parte delle Alpi “alla spicciolata” potremmo dire, per piccoli gruppi, magari di più famiglie, certo con anziani, donne e bambini, in un viaggio che comunque restava pericoloso, denso di incognite e che forse nasceva dall’urgenza di trovare nuove aree a pascolo che nelle terre di provenienza cominciavano a scarseggiare per il sovrappopolamento delle valli. La marcia si fermava in genere nel Canton Ticino e nei Grigioni in Svizzera, in Tirolo, in Austria, in Liechtenstein e da noi in Piemonte e Valle d’Aosta e dove questo popolo coriaceo si stabiliva nascevano villaggi costituiti da quelle bellissime case in legno, gli stadel, che ancora oggi punteggiano le valli sotto il Monte Rosa e rappresentano il vanto di località come Macugnaga e Alagna in Piemonte e le due Gressoney (La-Trinité e Saint-Jean) e Issime in Valle d’Aosta. Qui si viveva di agricoltura e di allevamento, in comunità che salvaguardavano la propria integrità culturale e la propria identità mantenendo vivo il contatto con la madrepatria e scoraggiando per esempio il matrimonio con “stranieri”.
Ma ancora una volta il destino avrebbe rimescolato le carte: alla fase calda del clima, seguì un periodo di freddo inusuale, la “Piccola era glaciale” che sarebbe durata fino a metà Ottocento e avrebbe chiuso a poco a poco nel ghiaccio tutti i valichi. I villaggi Walser non solo si ritrovarono bloccati gli accessi al Vallese e alla Francia ma l’impossibilità di continuare a praticare le attività su cui la loro economia fino a quel momento si era si fondata li portò a privilegiare il commercio. I gressonari in particolare si specializzarono nei tessuti, spingendo i loro traffici fino alla Germania meridionale. E di stoffe si occupava, almeno dal 1500, la famiglia Menabreaz (in origine il cognome si ornava di una bella z finale) che a un certo punto della sua storia si era trasferita da Gressoney a Winthertur dove possedeva un negozio rinomato per la qualità delle merci. Di quello avrebbe potuto continuare a vivere, e a prosperare, se non fosse che a metà circa dell’Ottocento il capofamiglia di allora, Jean Joseph François, si lasciò convincere da un altro gressonaro, Anton Zimmermann, a voltare completamente pagina e mettersi in società con lui che già possedeva una birreria ad Aosta. Fu l’inizio di un idillio, quello tra il walser e la bionda, intesa come bevanda, che non si sarebbe più interrotto.
Nel frattempo, più precisamente nel 1846, a Biella veniva aperta una birreria di cui proprietari erano un certo Welf, anche lui nativo di Gressoney e walser, e i fratelli Caraccio che invece erano “locali” e nella cittadina gestivano una caffetteria. La scelta di Biella per una produzione come quella birraria non era casuale: la birra è composta dal 97% da acqua che in quel territorio è ottima, con un residuo fisso bassissimo tanto che è acclamata come la più leggera d’Europa. Avere a disposizione acqua buona è già un bel passo avanti per avere una buona birra.
Però gli ingredienti non sono tutto, ci vuole anche capacità, il know how come lo si definirebbe oggi, e ben presto i tre neoimprenditori (che nel frattempo erano diventati due, i soli Caraccio, perché il terzo socio si era ritirato) si resero conto della mediocre qualità della loro produzione. Fu così che nacque in loro l’idea, nel 1854, di chiamare a Biella ad aiutarli Menabrea e Zimmermann che faranno ben presto un salto di qualità: già lo stesso anno affittano la birreria e dopo una decina di anni la acquistano, per la cifra di circa 95.000 lire dell’epoca.
I piani di Giuseppe (nel frattempo l’italiano è diventato lingua ufficiale e così appare il nome del gressonaro sui contratti) hanno una direzione ben definita: dopo qualche anno rinuncia alla sua quota della birreria aostana e all’uscita di Zimmermann da quella di Biella, nel 1872, fonda la “Fabbrica di Birra e Gazeuse G. Menabrea e Figli” dove i figli, almeno quelli coinvolti, sono Carlo e un giovanissimo Alberto. Vi starete chiedendo che cosa c’entra la gazeuse con la birra… Ai tempi di cui vi stiamo raccontando, la produzione di birra si fermava tra aprile (l’ultima era appunto la märzen ambrata) e settembre (e la prima birra dell’anno, pronta per ottobre, si festeggiava con l’Octoberfest). Il motivo di quello che era un vero e proprio divieto di legge era legato essenzialmente al calore dei mesi estivi che in assenza di sistemi di refrigerazione comprometteva la fermentazione da parte dei lieviti e quindi la buona qualità del prodotto. I birrifici perciò durante l’estate dovevano dedicarsi ad altre bevande gassate.
Torniamo ai Menabrea. Dei due fratelli, Alberto purtroppo muore presto, nel 1880, seguito di lì a un anno dal padre. Carlo ormai è solo a gestire il birrificio che va a gonfie vele, con la produzione concentrata su due prodotti, una pilsner chiara e una münchner scura, quest’ultima apprezzata perfino da Quintino Sella, all’epoca ministro delle finanze, che la loda più volte pubblicamente e in una lettera a Carlo scrive che “fa onore non solo alla sua fabbrica, ma anche a tutto il Biellese”. A questi giudizi lusinghieri fa seguito, nel 1882, la nomina a Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia, un riconoscimento prestigioso equiparabile all’odierno Ordine del Merito del Lavoro. Ma come sapevano gli antichi, la felicità degli umani rende gli dei invidiosi: Carlo si ammala di tisi e a soli 39 anni lascerà una giovane vedova, Eugenia Squindo, e tre figlie femmine, Albertina, Eugenia detta Genia e Maria, la maggiore delle quali ha solo dodici anni.
È a questo punto della vicenda che entra il terzo motivo che rende la visita al Me\Bo così interessante: diventa una faccenda di donne. Donne coraggiose e caparbie, che affrontano i momenti duri con un’intelligenza acuta che la placidità della vita famigliare rendeva invece opaca. Eugenia di birra e del birrificio non sa nulla. Fino a quel momento il suo ruolo è stato quello di moglie e madre, non riesce e non può oggettivamente nemmeno immaginare di mettersi lei al timone dell’azienda. Ha però un fratello, Pietro, che sarebbe disposto a occuparsene e anche a rilevarne la proprietà. Ed è a questo punto che Eugenia alza la testa: Pietro entrerà nel birrificio, ma solo come affittuario e per soli nove anni. Con l’esclusione dell’alloggio che Eugenia e figlie occupano all’ultimo piano come a sottolineare che i Menabrea continueranno a essere i padroni. E così sarà: anche se Pietro si è rivelato essere un amministratore capace e oculato, nel 1896 deve lasciare la fabbrica che Eugenia affida ai due generi, Augusto Antoniotti marito di Albertina ed Emilio Thedy (bisnonno dell’attuale amministratore delegato) sposo di Genia. A una condizione precisa, indicata chiaramente nel contratto: il birrificio mai dovrà cambiare il suo nome.
Il cambio di gestione non intacca il prestigio del marchio né la qualità del prodotto, anzi i premi e le medaglie si susseguono. Sembrerebbe il classico happy end se non fosse che la sorte ha in serbo un ennesimo scherzo crudele: proprio come il suocero, anche Emilio si ammala. Morirà a un’età ancora più giovane e ci saranno ancora una volta una vedova e degli orfani, cinque maschi, nel pieno dell’infanzia. Ma Genia cambia il copione: sarà lei a dirigere la Menabrea (Albertina era scomparsa quattro anni prima) fino a quando, nel 1925, non creerà con i figli ormai diventati grandi una nuova società. Che continuerà a chiamarsi Menabrea come lo è anche in questo terzo millennio in cui il birrificio si è affacciato, ancorato al suo passato, alle sue radici montanine, ma deciso a guardare sempre avanti per rimanere in sella a un mercato che premia sempre più l’innovazione e che vede in Italia 30 milioni di consumatori abituali di birra.
In questi anni le scelte strategiche sono sempre state in risposta all’esigenza di non “perdersi” nel mare indistinto di qualche multinazionale straniera: per esempio la decisione di entrare nel gruppo altoatesino Forst nel 1991, in un momento in cui cominciavano a formarsi le prime aggregazioni. “È un gruppo famigliare – spiega Thedy – gestito da veri birrai, un’azienda sana e interessata a tutelare i principi dell’industria della birra. Mantenere l’identità a quei tempi è stata una scelta importante”. Per il futuro la parola d’ordine è “internazionalizzazione”, già in atto da almeno una decina di anni e più e che si è ultimamente rafforzata sulla scia del made in Italy e dell’Italian style: “Siamo presenti già in 40 Paesi nel mondo, ma vogliamo sfruttare sempre più la forza del nostro marchio e della nostra heritage al di fuori dei confini nazionali”. I migliori ambassador? Thedy non ha dubbi: “Sono i nostri connazionali che si trasferiscono all’estero e che magari bevevano Menabrea quando erano giovani universitari”.
Riguardo poi alla sostenibilità gli investimenti dell’azienda in questo ambito sono stati considerevoli soprattutto per quanto concerne la sicurezza sul posto di lavoro, seguito da quelli tecnologici che hanno abbattuto gli sprechi d’acqua e portato a risparmi energetici importanti. Tra i passi prossimi anche un’Academy con l’obiettivo di far crescere la cultura birraria sia negli addetti ai lavori (chef compresi) sia nei consumatori che intanto hanno già imparato che la birra non è una bevanda per l’estate ma si consuma tutto l’anno e con qualsiasi pietanza.
E il caseificio Botalla? Tranquilli, non me lo sono dimenticato, fosse solo perché le donne c’entrano anche qui. Per arrivarci dobbiamo cominciare da quel Natale Botalla che nel 1947 apre un negozio di alimentari a Biella, proprio di fronte all’odierno Me\Bo. Di caseario in proprio c’era solo un burro, il burro Natale, che oggi ha perso il suo nome, ma è ancora parte della produzione del caseificio.
1978: dopo la morte di Natale Botalla e il passo indietro dei figli non interessati a calcare le orme paterne, marchio e negozio vengono acquisiti da Sandro Bonino (padre dell’attuale amministratore delegato), un passato in siderurgia e una grande passione per i formaggi. Sarà lui a dare una spinta decisiva all’azienda, facendola crescere nei numeri e nella qualità. Ma anche in questa storia, come dicevamo, le donne si sono ritagliate un ruolo speciale: sono la moglie di Bonino, Maria Teresa, che fin da subito affianca, e con entusiasmo, il marito, e di tre generazioni di casare, Ines Garda, la figlia Silvana e, dagli anni Novanta, la nipote Luisa. Sono loro ad aiutare Bonino che in via Ramella Germanin non aveva sufficiente spazio per la produzione, ma solo per la stagionatura (in virtù di quelle famose cantine comunicanti con Menabrea). E lo fanno ancora, dal loro stabilimento di Albiano d’Ivrea, nonostante Botalla oggi abbia un proprio caseificio e un nuovo impianto di stagionatura tecnologicamente all’avanguardia.
Anche questi personaggi trovano spazio nel Me\Bo e, come accade al piano inferiore dedicato a Menabrea, al racconto delle vite si mischiano le spiegazioni più tecniche corredate dagli arnesi del lavoro. Il sancta santorum è la “Stanza dello Sbirro”, nostro terzo pezzo iconico perché il celebre formaggio alla birra è il simbolo del museo oltre che della collaborazione e dell’amicizia che lo hanno fatto nascere. E a questo punto vale la pena spenderci due parole: per la sua preparazione non si deve mischiare la birra alla pasta bensì bagnare la forma nella birra ambrata e poi “impanarla” nella trebbia di cui abbiamo già parlato. Se invece “la bagna” è la birra di Natale, rossa e speziata, il risultato, dopo la stagionatura su assi di abete, sarà una pasta cremosa dal corredo aromatico sontuoso: lo Sbirro Gold.
All’uscita dal Me\Bo ci si ritrova in pieno centro storico di Biella con i suoi eleganti edifici alcuni dei quali datano al Trecento, e le sue “coste”, le ripide stradine medievali. “Essere qui è un plus, – dice Thedy – è un valore aggiunto oltre che un privilegio che le istituzioni locali ci hanno concesso e che negli anni abbiamo cercato sempre di contraccambiare”. Non è un caso che i 54 dipendenti di Menabrea vivano tutti a Biella così come tutti gli investimenti siano stati fatti utilizzando realtà locali. Il MeBo è stato un altro regalo alla comunità, come celebrazione di un legame “di sangue” che dura da oltre 170 anni. “Non abbiamo la forza economica per pubblicizzarci su reti televisive come le grandi multinazionali. Ma abbiamo qualcosa in più, un passato da raccontare, qualcosa che nessuno potrà mai portarci via”.