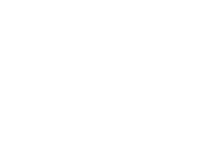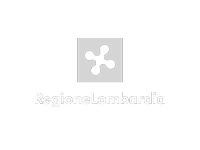Fai la curva e te lo trovi davanti, così all’improvviso da lasciarti quasi senza fiato: un monolite rosso la cui tonalità è resa ancora più intensa dal contrasto con il bianco accecante del vialetto che conduce all’ingresso. Le forme esterne sono avvolgenti, morbide e sinuose, in un richiamo “alle volute aromatiche che si sprigionano da una tazzina di caffè bollente”. A raccontare è Barbara Foglia, MUMAC Manager, dove MUMAC è l’acronimo di Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, che ospita “la più grande esposizione al mondo dedicata alla storia e alla cultura delle macchine per espresso professionali, un luogo unico che intende raccontare la storia dell’azienda e dei suoi principali brand (La Cimbali e FAEMA), ma soprattutto quella di un intero settore del Made in Italy e di tutti quei prodotti che ne hanno rappresentato le pietre miliari.” Un ex magazzino per ricambi, nel quartier generale del Gruppo a Binasco, che nel 2010 la famiglia Cimbali decide di trasformare in un museo per celebrare il centenario della fondazione dell’azienda che sarebbe caduto di lì a due anni. Scelta non scontata: la congiuntura economica in quegli anni era difficile, le aziende in Italia erano più o meno tutte in sofferenza e l’investimento su un progetto del genere era tale da generare più di una perplessità, forse un evento, anche se effimero, sarebbe stato più opportuno. Ma la passione prevale e il sogno diventa realtà. Più tardi Maurizio Cimbali, presidente del gruppo, scriverà: “Ci siamo confrontati in famiglia, mio cugino, i miei figli, la terza e la quarta generazione: la famiglia ha creduto fortemente nel progetto. Se non lo facciamo noi – ci siamo detti – che produciamo macchine per caffè da cent’anni, un museo delle macchine per caffè non lo fa nessuno. E questa è l’occasione giusta” (MUMAC, Museo della macchina per caffè – AA.VV.). Tuttavia questa realtà forse non avrebbe mai visto la luce senza il contributo fondamentale di Enrico Maltoni, curiosa figura di collezionista che dal 1988, data del suo acquisto di una FAEMA Marte a un mercatino di bric-à-brac, raccoglie in giro per il mondo e restaura macchine per caffè tanto da esserne diventato uno dei massimi esperti oltre che un sapiente intenditore della bevanda. L’incontro “fatale” tra Maltoni e la Cimbali era già avvenuto, e anche da un bel po’. Erano gli anni Novanta e al Mercante in Fiera, il celeberrimo appuntamento di Parma dedicato all’antiquariato e al modernariato, Maurizio Cimbali si era imbattuto in un piccolo stand con alcune vecchie macchine per caffè della sua azienda. L’espositore era proprio Enrico Maltoni. Inevitabili la presentazione, la lunga chiacchierata sull’oggetto dei loro comuni interessi e il germoglio di un rapporto di stima e simpatia reciproche che nel tempo cresce al punto che, quando comincia a concretizzarsi l’idea del museo, Maltoni decide di allocarvi una parte della sua sterminata collezione: ben 200 pezzi che si aggiungono al centinaio della collezione Cimbali. È nato il MUMAC.
L’esposizione segue un criterio cronologico e permette quindi di avere una visione completa dell’evoluzione del design e della tecnologia della macchina per caffè espresso professionale dalla sua prima comparsa, alle soglie del XX secolo, fino a oggi. Ma fosse solo questo il museo non avrebbe quel fascino peculiare che invece lo contraddistingue e che spiega l’affollamento delle sue sale da parte di un pubblico che non è di addetti ai lavori. Ciò che lo rende davvero unico è, per citare Foglia, il fatto di “riprodurre in ogni sala le atmosfere tipiche del periodo, con gli arredi caratteristici, musiche di sottofondo e grafiche evocative dell’epoca. Il MUMAC quindi è più di una rassegna di macchine per caffè: è un viaggio nel tempo alla scoperta della storia dell’espresso attraverso suoni, forme, colori e sapori”. Una panoramica lunga un secolo dei mutamenti del costume e della cultura del nostro Paese, un amarcord che non manca di emozionare soprattutto i meno giovani, ma è capace di coinvolgere anche chi, al contrario, giovane lo è.
È ora quindi di partire per quel viaggio.
La prima tappa ci porta in un caffè dei primi del Novecento. Già alla prima occhiata si capisce che non è un posto per tutti, quella tazzina è ancora un bene di lusso, per gran signori e belle dame ingioiellate, e la location è all’altezza dello status della clientela. Tutto parla il linguaggio della raffinatezza: il bancone art nouveau (originale del 1914) con piano in marmo e boiserie, la scaffalatura a specchio dove trovano ordinatamente posto i sifoni per l’acqua di seltz, le belle bottiglie in cristallo intagliato e quelle più plebee (sull’ultimo ripiano in alto per celarle in parte allo sguardo) in vetro verde, i bicchierini da vermouth e da rosolio e il paravento con i vetri multicolori a piombo. Sul tavolino adiacente, due tazzine bordate di oro, a rimarcare la ricercatezza del locale. Ma quello che attira maggiormente l’attenzione è la magnifica macchina per caffè che troneggia sul bancone: una Condor Extra Lusso del 1926, imponente ed elegantissimo cilindro sovrastato da un rapace ad ali spiegate. Non è una delle prime macchine da caffè, in esposizione ci sono modelli precedenti come la caffettiera dei Fratelli Beretta (1900), l’Ideale della Pavoni (1905), la Moyen Bezzera (1920) e altri, ma tutti condividevano il medesimo principio costruttivo: una caldaia verticale con un sottostante sistema di riscaldamento a gas e due rubinetti ai lati. L’acqua in ebollizione, insieme al vapore, passava attraverso il caffè e la bevanda nel giro di qualche minuto scendeva nella tazzina. Era un caffè molto diverso da quello di oggi: scuro, con un acre gusto di bruciato, senza crema, ma le sue caratteristiche (la novità, la velocità di preparazione, la macchina, sbuffante come un treno, che lo produceva) rispondevano benissimo ai valori imperanti di quell’esordio del Novecento che esaltava il progresso in tutte le sue forme. Anche l’attenzione per l’estetica le accumunava: forme curvilinee, finiture in bronzo, smalti, decorazioni floreali o geometriche le rendevano quasi sculture da esibire con orgoglio e pazienza se talvolta qualcuna esplodeva!
Finora non abbiamo citato uno dei personaggi fondamentali di questa storia, il torinese Angelo Moriondo, che per primo ebbe l’intuizione di utilizzare il vapore per l’estrazione della bevanda in grande quantità e per questo considerato il padre del “caffè istantaneo”, antecedente al caffè espresso. La sua macchina, di cui il museo espone una ricostruzione realizzata da Maltoni seguendo i disegni originali della seconda metà dell’Ottocento, venne presentata all’Esposizione di Torino del 1884 riscuotendo un enorme successo con i giornali dell’epoca che magnificavano la possibilità di “dare da una a dieci tazze di caffè ogni due minuti e fino a trecento in un’ora”. La differenza con le macchine future è che il caffè non era “espresso”, ma veniva preparato, come già detto, in quantità tutto in una volta e poi erogato a richiesta e quindi mai “fresco”. Sarà Luigi Bezzera nel 1901 a brevettare un’innovazione che avrebbe invece consentito di preparare il caffè tazza per tazza: il gruppo erogatore con il portafiltro per la preparazione di una sola porzione di caffè. Un brevetto che sarebbe presto stato comprato dalla Pavoni e che avrebbe portato alla realizzazione della prima macchina per espresso, l’Ideale, chiamata così proprio perché era la scelta giusta per potersi gustare tutto l’aroma della bevanda.
Ci si potrebbe chiedere perché tra tutti i nomi citati non compare Cimbali. La risposta è semplice: perché ancora non esisteva. O meglio, nel 1912 Giuseppe Cimbali, ramiere idraulico in quel di Milano, aveva sì una bottega che produceva caldaie per macchine per caffè, ma lo faceva per gli altri. C’è una bella foto di lui a quel tempo: braccia conserte, in giacca da lavoro, mascella quadrata serrata sulla quale non aleggia nemmeno l’ombra di un sorriso, aria seria e assorta. Trasmette l’idea di un tipo tosto, che sa quello che vuole. E lo si capirà negli anni Trenta, quando deciderà di comprare un’azienda sua cliente e di mettersi anche lui a produrre macchine per caffè.
Ci siamo così già traghettati alla seconda tappa, un lungo corridoio che proprio all’inizio espone la prima macchina per caffè di Cimbali, la Rapida, ancora a sviluppo verticale, ma con un design che già “sa di nuovo”. Siamo infatti nel ventennio Trenta e Quaranta nel quale è l’idea stessa di decorazione a essere messa al bando. Via i tralci fioriti e le curve, imperano invece volumi semplici, linee geometriche pulite, in una ricerca di essenzialità che impronterà di sé non soltanto gli oggetti quotidiani ma anche l’architettura (nelle foto alle pareti ne troviamo due esempi, il Foro Italico e il Palazzo della Civiltà Italiana, che ne rendono bene la straniante aura metafisica che li pervade). È il Razionalismo, congruente al clima austero del periodo storico tra le due guerre che investe anche il settore delle macchine da caffè: pur non essendoci un’assoluta battuta d’arresto nella produzione, la tecnologia non fa grandi passi in avanti. Solo negli anni Quaranta qualcosa cambierà. Innanzitutto cominciano ad apparire macchine per caffè orizzontali, un’innovazione che facilita, e non di poco, il lavoro del barista che si trova i gruppi erogatori tutti sullo stesso lato evitandogli di dover girare intorno alla macchina per servire i clienti. E poi con la nuova forma, un accessorio impensabile nelle macchine precedenti che spesso erano sormontate da una cupola: lo scaldatazze, cioè uno spazio ricavato sopra la caldaia e in grado perciò di sfruttarne il calore per intiepidire la porcellana. Infine il sistema ibrido di alimentazione: siamo in guerra e la possibilità di far funzionare le macchine sia con il gas sia con l’elettricità, nel caso uno della due fonti energetiche venga a mancare, è preziosa. Ce ne saranno addirittura alcune a carbone. Poi, sul finire del periodo un’altra novità: i designer si affacciano sulla scena e le macchine per caffè cominciano a mostrare la mano creativa di personaggi del calibro di Giò Ponti. Sarà quest’ultimo a disegnare nel 1947 per la Pavoni quella che viene chiamata “la Monna Lisa del MUMAC” e che è il nostro primo pezzo iconico: la D.P. 47, soprannominata “la Cornuta” per la forma ricurva dei gruppi erogatori. “L’esemplare esposto al museo – ci spiega Foglia – è uno dei due esistenti al mondo ma il secondo appartiene a una collezione privata e quindi non accessibile al pubblico. Proprio per questo è una delle macchine più richieste per prestiti: icona di design, è stata al Deutsches Museum di Monaco, al Musèe des Arts Décoratifs di Parigi, in Triennale a Milano e in altre sedi espositive prestigiose”. A fronte della sua originalità totalmente stravolgente rispetto agli stilemi dell’epoca (è ancora oggi considerata la più bella macchina per caffè mai realizzata), ebbe poco successo forse perché arrivò troppo tardi: la sua tecnologia, ancora a vapore, sarebbe stata di lì a pochissimo soppiantata da un’invenzione che avrebbe cambiato la realtà dell’espresso: la leva.
L’ambiente successivo è un tipico bar degli anni Cinquanta: l’atmosfera formale e composta che aveva caratterizzato i caffè dell’inizio del Novecento è stata spazzata via dall’idea che al bar ci si vada non soltanto per bere un caffè, ma per vivere un momento di socialità. Si guarda la televisione, si leggono le riviste (a disposizione dei clienti sul tavolino), si ascolta la musica del juke-box, si gioca al classico biliardino, tutti oggetti immancabili, e poi si respira quell’eccitante american style con le sue superfici cromate e scintillanti e le forme che ricordano le automobili dell’epoca, soprattutto le Cadillac, incarnazione del sogno americano che tutti vogliono vivere in qualche modo. Sul bancone una FAEMA Urania nella quale spicca una leva. È proprio questa la rivoluzione di cui si parlava: non è più il vapore a spingere l’acqua, scaldata in una caldaia, fino al portafiltro bensì la forza del braccio applicata alla leva. Grazie a essa (soprattutto alla pressione di 9 bar che viene raggiunta), l’espresso diventa la bevanda che tutti conosciamo: denso, con un buon sapore – gli oli essenziali del caffè non vengono più bruciati dal vapore – e soprattutto coronato da quello strato di crema che è uno dei piaceri, anche visivi, associati al caffè. Protagonista di questo cambiamento epocale fu, nel 1948, Achille Gaggia che già da anni studiava come riuscire ad abbandonare l’uso del vapore per l’estrazione del caffè. Il fatto è che Gaggia ai tempi non produceva macchine per caffè, gestiva un bar a Milano, ma era un vero e proprio inventore con la visione di un moderno uomo di marketing: osservava le abitudini e le reazioni dei clienti e poi nel magazzino del locale sperimentava come cambiare quello che gli sembrava non li convincesse. Così, dopo aver brevettato il gruppo erogatore a leva lo propone a Ernesto Valente, un’altra figura mitica di imprenditore del Dopoguerra, specializzato in piccoli elettrodomestici: sua è la FAEMA, un nome che da quel momento in avanti sarà sempre più presente nel mondo del caffè. E infatti dal connubio tra i due nasce la Gaggia Classica, sottotitolo “CREMA CAFFÈ NATURALE – funziona senza vapore”. La prima di una lunga serie di macchine con leva che rapidamente soppiantarono qualsiasi altro modello sul mercato: alla crema adesso nessuno voleva più rinunciare, anche se a dire la verità all’inizio un po’ di diffidenza c’era perché si pensava fosse qualcosa di aggiunto in un secondo tempo. Anche Cimbali si butta nella mischia e la sua macchina è quasi una provocazione: si chiama Gioiello e viene presentata alla Fiera di Milano nel 1950 in uno scrigno di velluto. Questi due modelli, esposti nel museo insieme a molti altri celebri come la Concorso della Pavoni (1956), la Granluce (1955), la Rubino (1956) e la Brillante (1952) tutte e tre della Cimbali, sono davvero splendidi con le loro carrozzerie che esaltano la luce nei mille riflessi delle loro sfaccettature. Due macchine sono particolarmente curiose: la Lollobrigida della San Marco (1952), ispirata alle curve mozzafiato della celebre attrice, e la Fortuna della Universal (1958) che poteva essere personalizzata grazie ai pannelli in ceramica posti ai lati della macchina e raffiguranti i tipici paesaggi italiani.
Un primo piano di Jurij Gagarin introduce al decennio dopo, gli anni Sessanta e Settanta, e al corridoio dove le star indiscusse, insieme a Neil Armstrong, primo uomo sulla Luna, e a dei giovanissimi Rolling Stones incombenti dalle pareti, sono la Pitagora di Cimbali e la E61 di FAEMA, entrambi nostri pezzi iconici. È un periodo all’insegna del design, negli arredi come negli elettrodomestici, e le macchine per caffè non fanno eccezione perché sono oggetti entrati ormai nella dimensione quotidiana delle persone. La ricerca di nuovi materiali (come la plastica) e l’affermazione di una grande libertà cromatica (ricordiamoci che siamo negli anni della Pop Art) dominano la produzione che inizia anche a guardare oltreconfine e ambisce ai grandi numeri. La prima macchina per caffè progettata per una catena di montaggio è proprio la Pitagora, firmata dai fratelli Castiglioni e vincitrice dell’edizione 1962 del Compasso d’Oro, un riconoscimento che rimarrà unico nella sua categoria. Dimenticate le linee aerodinamiche o voluttuose degli anni precedenti, adesso è la geometria rigorosa a tenere banco, forma che aiuta a produrre in serie e a viaggiare per il mondo perché la Pitagora si può impilare e più pezzi possono essere inseriti nello stesso imballaggio con un bel vantaggio per la logistica. La sua struttura (“la carrozzeria era costituita da soli diciassette pezzi con la parte anteriore che si poteva alzare come il cofano di un’automobile” ci dice Foglia) semplificava la manutenzione e l’ispezione nel caso di problematiche e in più il cliente poteva scegliere tra una gamma di tinte per personalizzare il suo acquisto. E che dire della E61? Innanzitutto che viene prodotta ancora oggi, non molto dissimile dal primo modello, il che la dice lunga sul suo gradimento. Poi che introduce un’innovazione che semplifica parecchio il lavoro del barista: l’elettropompa volumetrica che, posta sotto il bancone e collegata alla rete idrica, consente di spingere l’acqua già alla pressione di 9 bar all’interno della caldaia. Via la leva, scomoda e a volte pericolosa, adesso basta schiacciare una levetta. Infine una curiosità: la sigla. E61 faceva riferimento all’eclissi totale di sole avvenuta nel 1961: Ernesto Valente era un appassionato di astronomia – il che spiega tra l’altro i nomi con cui erano stati battezzati alcuni dei modelli FAEMA (Urania, Saturno…) – e intendeva così unire due avvenimenti sottolineati come straordinari, il lancio sul mercato di una macchina per caffè molto innovativa e un fenomeno che in Italia non si sarebbe ripetuto in tutto il XX secolo.
Non si può lasciare questo momento storico davvero mitico senza ricordare il connubio tra ciclismo e caffè che proprio allora si consolida. FAEMA è tra le prime aziende a intuire la potenza della comunicazione di un marchio se legata a uno sport “popolare”: l’aveva capito da quando le sfide tra Coppi e Bartali erano state in grado di catalizzare gli umori e le discussioni di un’intera popolazione. Una stella tra i tanti campioni che corsero con la maglia FAEMA: Eddie Merckx, il “cannibale” (il suo soprannome per la sua fame di vittoria e la capacità di “papparsi” gli avversari).
Il passaggio alle due sale successive, che ci portano dagli anni Ottanta al nuovo millennio, è ancora una volta un cambio totale di atmosfera perché il racconto del costume lascia il passo all’esaltazione dell’elettronica. Né può essere diversamente perché è proprio questo aspetto a caratterizzare ogni campo della società e quindi anche l’evoluzione delle macchine per caffè. FAEMA Tronic del 1983 sarà l’antesignana: se la linea, disegnata da Sottsass e Cibic, sembra ancora debitrice del decennio precedente, non si può dire lo stesso della funzionalità visto che per la prima volta una pulsantiera consente di gestire il dosaggio della bevanda per la tazzina. Una prestazione che sarà implementata nelle macchine superautomatiche successive grazie alle quali si avrà a disposizione tutto un repertorio di bevande a base di caffè e latte fresco. Lustro dopo lustro le macchine diventano sempre più tecnologicamente avanzate, ergonomiche, di semplice utilizzo, sostenibili e performanti. I modelli esposti sono tanti, alcuni dall’aspetto davvero fantascientifico, ma la regina in questo senso è forse la Cimbali M100, nata proprio in occasione del centenario dell’azienda, di cui un esploso (per di più parziale visto che contempla solo il 30% dei pezzi) è esposto nell’ultima sala del museo, il LAB, per far capire quanta complessità si celi dietro una semplice tazzina di caffè.
Se è vero che il caffè più che una bevanda è un fenomeno sociale, allora un museo incentrato su di esso deve rispecchiare le dinamiche di un mondo in continuo cambiamento, assumendo un ruolo attivo in cui tenere sempre aperto il dialogo con la collettività attraverso iniziative che la coinvolgono a vari livelli. E in effetti il MUMAC, per usare ancora una volta le parole di Barbara Foglia, oltre che uno spazio dove si racconta una storia straordinaria, è un vero e proprio hub culturale grazie alla Library, ricca di oltre un migliaio di volumi a tema caffè, all’Archivio storico che raccoglie circa 25.000 documenti tra brochure, cataloghi, brevetti, disegni originali, fotografie, pubblicità, riferibili sia al mondo Cimbali sia a diverse altre realtà imprenditoriali che hanno fatto la storia del caffè e delle macchine per prepararlo, all’Academy, luogo di formazione e diffusione della cultura del caffè sia per professionisti che per appassionati, e infine all’Hangar 100, uno spazio polifunzionale per iniziative temporanee, convegni, presentazioni. Il museo diventa così un crocevia di saperi ed esperienze diversi che lo rendono un luogo vivo e mai obsoleto nei contenuti proposti. Un altro esempio è la partecipazione alla Prima Diffusa del Teatro alla Scala, un appuntamento, racconta Foglia con orgoglio, “che nel 2023 sarà alla sua settima edizione dal 2016, anno in cui è iniziato il supporto di MUMAC e del gruppo Cimbali all’ente lirico. Evento seguitissimo, unisce due realtà simbolo di eccellenza del panorama italiano: da una parte il MUMAC, ambasciatore di uno degli elementi più rappresentativi del Made in Italy, dall’altra un teatro che è uno dei più prestigiosi ambasciatori della cultura italiana nel mondo”. Il museo ha anche svariate collaborazioni con altri musei come il Kartell Museum e la Fondazione Achille Castiglioni, è membro dell’associazione Museimpresa e di ICOM (l’International Council of Museums), è gemellato con il Museu Do Café di Santos in Brasile, apre le sue porte in occasione delle giornate del FAI, in poche parole è presente laddove si parla non solo di caffè, ma anche di design e di cultura nell’accezione più ampia del termine. Senza dimenticare il rapporto vivace con il mondo della scuola attraverso laboratori che si rivolgono a studenti di ogni età, da quelli della primaria fino agli universitari toccando i temi più vari, innovazione e heritage, tecnologia, design, proprietà industriale. La volontà di servizio al territorio ha forse toccato il punto più alto ed emozionante durante il periodo della pandemia: “in occasione della campagna vaccinale contro il Covid-19 nel marzo 2021 MUMAC è diventato hub di riferimento per le vaccinazioni di massa arrivando a oltre 34.000 somministrazioni in 5 mesi” – ricorda Foglia – “Non solo. Quando in quell’occasione la maggior parte dei musei si è trovata, per così dire, senza voce, abbiamo cercato di mantenere il contatto con i nostri interlocutori andando a intensificare le iniziative on line”. Due esempi: “Un libro nel tempo di un caffè”, una serie di video in cui venivano narrati alcuni dei volumi presenti nella Library, e “Be our social Guest”, in cui vari personaggi raccontavano la loro vita durante il lockdown sorseggiando un caffè. C’è qualcosa di commuovente in questa pervicace presenza del “gigante rosso”. E, credo, anche molto da imparare.